Grillo ha ragione sull'art. 67 della Costituzione
>> domenica 3 marzo 2013
Ogni parlamentare – senatore o deputato – rappresenta la Nazione, e cioè l’Italia. Fin qui nulla di straordinario. È un principio cardine, difficilmente contestabile, posto che il Parlamento è l’organo legislativo supremo e i membri del Parlamento sono espressione del popolo italiano. Se proprio si volesse fare un discorso ozioso sul punto, ci si potrebbe domandare cosa si intende per nazione: l’intero corpus elettorale, e cioè i cittadini in quanto «popolo italiano» ex-art. 1 Cost., oppure anche chi non ha il diritto di voto, come l’immigrato con il permesso di soggiorno?
Un quesito decisamente interessante che però esula dalla mia riflessione. Quello che qui mi preme rilevare è la seconda parte della norma: «ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato». Che significa?
Nel diritto privato il contratto comporta che chi si assume l’obbligo di fare o non fare una determinata cosa debba poi adempiervi secondo le modalità stabilite nel contratto stesso. La conseguenza dell’inadepimento o dell’inesatto adempimento è la risoluzione del contratto e magari il risarcimento del danno a favore del beneficiario, salva l’azione di «esatto adempimento».
Ebbene questo principio non è affatto applicabile al rapporto elettorale che si instaura tra eletto ed elettore. Il parlamentare che non rispetta il proprio mandato elettorale nei confronti dell’elettore non viola alcuna norma «contrattuale». Non è tenuto in altre parole a rispettare le scelte di fondo dell’elettore; quelle scelte che magari hanno spinto lo stesso elettore a preferire quel parlamentare (o il partito in cui è stato candidato) a un altro.
Ebbene questo principio non è affatto applicabile al rapporto elettorale che si instaura tra eletto ed elettore. Il parlamentare che non rispetta il proprio mandato elettorale nei confronti dell’elettore non viola alcuna norma «contrattuale». Non è tenuto in altre parole a rispettare le scelte di fondo dell’elettore; quelle scelte che magari hanno spinto lo stesso elettore a preferire quel parlamentare (o il partito in cui è stato candidato) a un altro.
Questo è il significato di «senza vincolo di mandato». Il senatore o il parlamentare eletto è «irresponsabile» nei confronti dell’elettore. In altre parole, non gli deve nulla in termini di lealtà politica e in termini di «buona fede» elettorale. Ma per fare un esempio iperbolico (ma poi mica tanto!), ecco cosa intendo dire traducendo il tutto in termini pratici: supponiamo che Caio elettore voti PDL perché non vuole che vengano approvati i matrimoni gay e guarda caso, il programma del PDL rigetta espressamente queste forme inedite di matrimonio. Ebbene, Caio elettore, affidandosi a questo punto del programma, nella propria circoscrizione vota PDL e conseguentemente vota per il suo candidato, Tizio, il quale viene poi eletto. Tizio, dunque, entra il Parlamento nelle file del PDL, ma appena dopo qualche mese, dichiara di voler sostenere i matrimoni gay e decide di abbandonare il PDL e il gruppo parlamentare, per iscriversi in quello del PD dal quale promuove tutte le iniziative parlamentari per fare approvare la norma. Un comportamento questo decisamente da banderuola e delle peggiori… Eppure, Tizio è protetto nelle sue scelte: l’art. 67 cost., sul punto è chiaro. Egli è libero – secondo Costituzione – di tradire il proprio elettorato e le aspettative dei propri elettori. Nonostante Caio lo abbia prescelto per rappresentarlo proprio perché contro i matrimoni gay, non può fare nulla davanti al voltagabbana del poco onorevole Tizio. Dovrà rassegnarsi a vedere approvata una norma che lui non voleva.
Tornando dunque al paragone con i contratti privati, il comportamento di Tizio, in termini meramente contrattuali, avrebbe invece avuto conseguenze precise: avrebbe permesso a Caio di agire contro Tizio per costringerlo ad adempiere precisamente, oppure per risolvere il contratto e domandare il risarcimento del danno. Perché Caio in questo senso è stato tradito nella propria buona fede contrattuale. Si è affidato alle promesse di Tizio.
Giuridicamente parlando il rapporto elettorale purtroppo non può essere paragonato a un rapporto meramente privatistico. La sua disciplina è esclusivamente pubblicistica ed è sancita a livello costituzionale. Sul punto, il principio di cui all’art. 67 Cost., non può essere aggirato sostenendo che tra il membro del parlamento e l’elettore sia stato concluso un contratto; in parecchi ci hanno tentato, ma puntualmente hanno fallito. La natura dei due fenomeni è diversa e tale deve rimanere.
Eppure non si può negare che questo sia un grave difetto costituzionale; un difetto che ha di fatto alimentato il fenomeno del trasformismo e delle maggioranze variabili. Il costante flusso di parlamentari da un gruppo all’altro rende infatti gli esiti elettorali relativi e incerti. L’elettore, quando vota, non sa mai se la maggioranza che prevale rimarrà la stessa per tutta la legislatura oppure se a un certo punto cambierà, divenendo minoranza, e senza che una consultazione elettorale, e dunque la sua opinione, suggelli questo esito. Si è arrivati all’estrema conseguenza, paradossale e frustrante, in cui la volontà popolare non ha più alcuna rilevanza, rilevando piuttosto la volontà dei singoli parlamentari di dare vita a maggioranze diverse rispetto a quelle prescelte dal popolo sovrano che li ha eletti.
Una stortura questa che non è più accettabile in un contesto dove non è il parlamentare a dover decidere, ma è l’elettore al quale il parlamentare deve rendere conto. Se il cittadino vota un partito e i suoi candidati, deve poter essere sicuro che la politica promossa da quel partito venga attuata. Se su questo aspetto vi potranno essere delle inadempienze, non devono dipendere dalla volubilità politica dei singoli membri del parlamento, ma dalla incapacità di quel gruppo di portare avanti quella politica.
Ecco perché sono dell’idea che l’art. 67 Cost. debba essere modificato e debba prevedere il «vincolo di mandato». L’elettore ha il diritto di scegliersi effettivamente i suoi rappresentanti politici. È anche questo un principio costituzionale inalienabile – dedotto da quanto dispone l’art. 1 Cost., comma 2 – che di fatto e di diritto viene disatteso proprio dall’assenza del vincolo di mandato. Se questo fosse previsto, non esisterebbero i giochi di potere e le maggioranze variabili. Gruppi come FLI non sarebbero potuti nascere nel palazzo e il loro dissenso sarebbe stato annullato dal vincolo di mandato che avrebbe comportato il ritorno al voto nei collegi dove quei parlamentari furono eletti. Sarebbero stati gli elettori, in altre parole, a dire se FLI era legittimato a esistere, e non certo un Presidente della Camera… Soprattutto con il vincolo di mandato non sarebbero possibili i ribaltoni, poiché ogni decisione contraria all’esito elettorale comporterebbe il ritorno davanti al corpo degli elettori.










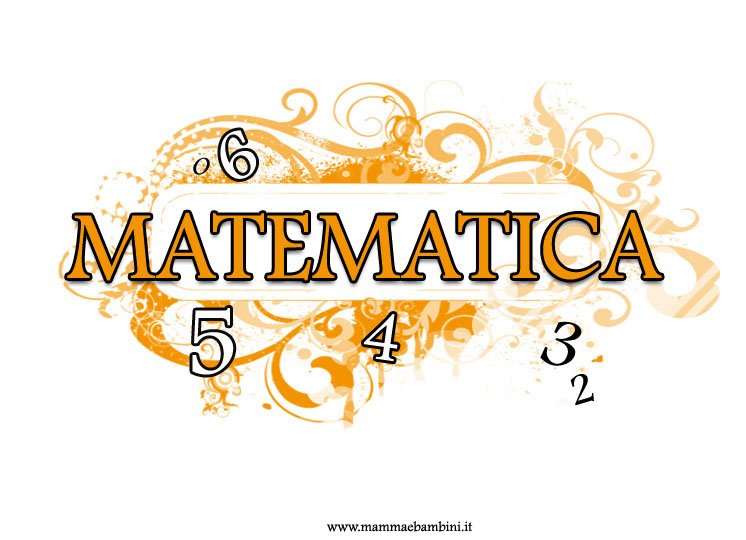
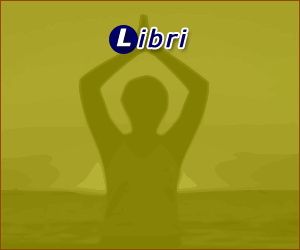






0 commenti:
Posta un commento