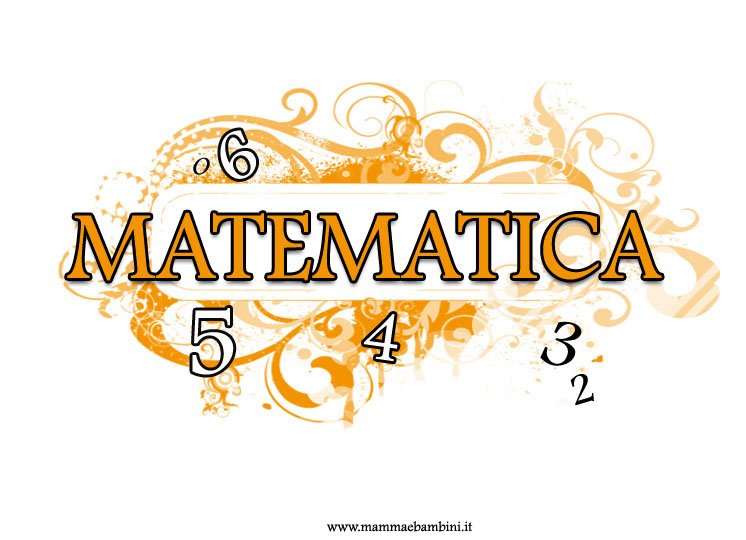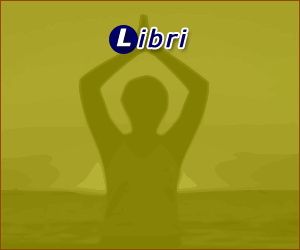Tuttavia, confrontando gli argomenti trattati dai due e le problematiche della società che li circonda, si potranno meglio individuare affinità e differenze.
Pirandello vive la crisi della sua età, assiste al morire degli ideali romantici, all' insufficienza di quelli naturalistici e veristi, al nascere del decadentismo.
Egli, rispetto a D'Annunzio, rappresenta l'altro volto del decadentismo, il più triste e disilluso, spietato e consapevole.
In un primo periodo aderisce al naturalismo e, obbediente ai suoi dettami, ricerca nelle vicende umane lo snodarsi della catena causa- effetto; ma ben presto entra in crisi perchè alla narrazione naturalista che si avvia verso esiti previsti si sostituisce quella di una realtà irrazionale che stabilisce fra gli uomini legami imprevedibili e casuali.
Attraverso: " L 'esclusa ", " Il turno ", e " Il fu Mattia Pascal ", Pirandello arriva a: " Si gira ", come fu chiamato nella stesura definitiva: " Quaderni di Serafino Gubbio operatore " che è l' ultimo anello della catena che lo porta al teatro come unica possibile forma di comunicazione.
Vista l' insufficienza dei valori naturalistici e l' impossibilità di sostituire a questi, rivelatisi falsi, dei nuovi valori, arriva alla coscienza dell' impossibilità di pronunciare qualsiasi giudizio sulla vita e le azioni umane; la vita quindi non può che ridursi a un susseguirsi ininterrotto di scene, si riduce, insomma, a puro teatro.
E al teatro come unica possibile forma di rappresentazione del reale, Pirandello si volge.
Eduardo De Filippo nasce, possiamo dire, nel teatro ; figlio d' arte comincia a recitare nella compagnia di Scarpetta a quattro anni.
In un suo scritto Eduardo afferma: " Lo sforzo disperato che l' uomo compie nel tentativo di dare alla vita un qualsiasi significato è teatro."
Le prime commedie di Eduardo sono, riallacciandosi alla tradizione scarpettiana, delle farse ma già contengono i germi di quell' amarezza che si individuerà nelle commedie della maturità.
Al 1933 risale l' incontro fra i due; Eduardo propose al grande drammaturgo di fare della novella: " L' abito nuovo ", una commedia.
Insieme prepararono la sceneggiatura che Eduardo volse in dialetto napoletano.
Il 10 dicembre 1936 Pirandello moriva senza veder rappresentata la commedia, lasciando in Eduardo il rimorso di non averla messa prima in scena.
Ricordiamo un elemento presente in entrambi: l' umorismo.
Da Pirandello è visto come " il sentimento del contrario ", scomposizione ironica della realtà che serve da preludio alla distruzione dei suoi valori e miti fittizi; da Eduardo come " la parte amara della risata ed è determinato dalla delusione dell' uomo che è, per natura, ottimista."
Passando ora alla produzione pirandelliana più feconda, notiamo i caratteri fondamentali di una realtà priva di valori; al capovolgimento di quelli ottocenteschi si erano create delle verità fittizie, usate ipocritamente come vere.
Ecco quindi l' impossibilità di una verità certa in: " Così è se vi pare " dove il pensiero umano crea e distrugge la realtà, la fa comparire e scomparire fino a culminare nelle parole di colei che, di volta in volta è la figlia o la moglie: " La verità è solo questa... per me io sono colei che mi si crede".
Ecco la disperazione dell' uomo che si vede assegnare dal destino e dagli altri una parte e a quella deve restare legato senza possibilità di scampo, condannato dalle convenzioni sociali e dall' ipocrisia degli altri a recitarla fino in fondo.
E' il dramma di Angelo Baldovino ne: " Il piacere dell' onestà " e lui a questa schiavitù si ribella; è il dramma di
Leone Gala ne: " Il gioco delle parti " il quale non si ribella alla sua parte ma, attraverso di lei, si vendica.
E', infine il dramma di Martino Lori che in: " Tutto per bene " scopre con orrore che la parte assegnatagli dal gioco non è quella da lui voluta, che la forma che lo chiude non gli appartiene.
Questi temi trovano la massima espressione artistica in: " Sei personaggi in cerca d' autore ". L' uomo non può uscire dalla parte che gli è stata assegnata, che lo blocca e lo cristallizza, non può vivere un' esperienza diversa perchè in quella parte gli altri, inevitabilmente, lo ricacciano cercando di difendere, a loro volta, la propria ragion d' essere.
In: " Ciascuno a suo modo " la tragedia umana raggiunge il culmine e rivela l' assurdo di una vita ridotta ad apparire illusorio: a questo punto Pirandello si arresta e si allontana dal teatro per circa due anni.
Eduardo ha diviso le sue commedie in due parti: " Cantata dei giorni pari " e " Cantata dei giorni dispari "; la prima contiene le commedie precedenti alla seconda guerra mondiale, la seconda quelle del periodo post-bellico.
Il giudizio di Eduardo nel 1945 sulla prima raccolta è: " In quelle commedie ho tenuto in vita una Napoli che era già morta in parte e in parte tenuta in vita dalla paternalistica premura del regime fascista.".
La " Cantata dei giorni dispari " fa invece riscontro a un' epoca nuova che ha conosciuta la rottura causata dalla guerra.
Il mutamento maggiore è che Dio, religione, autorità, famiglia sono stati messi sotto accusa e contestati.
L' uomo si è trovato solo davanti alla vita senza riuscire a darle un significato, solo tra altri uomini con i quali non trova punti in comune e non riesce a comunicare; nè a ciò è seguita la nascita di nuovi valori.
Quindi anche la maturità di Eduardo si sviluppa in un periodo, anche se storicamente diverso, confuso come quello pirandelliano.
Ma, mentre per Pirandello è in gioco l' essere dell' uomo, la sua personalità, la sua struttura psicologica, quei connotati che fanno di una persona un' entità inconfondibile, Eduardo osserva soprattutto il modo di essere dell' uomo, il suo comportamento e inserimento nei confronti della società.
Per Eduardo ogni personaggio ha dei precisi connotati che non vengono messi in discussione; piuttosto è la società che coarta l' uomo che ne indirizza le azioni in una direzione piuttosto che in un' altra, che lo avvolge in una rete di ipocrisie, di sospetti, di incomprensioni.
A volte i suoi protagonisti sono ingenui e disarmati come Luca in: " Natale in casa Cupiello " che non vede il male intorno a sè e, quando ne è toccato, non resiste all' impatto e muore.
Anche Gennaro di: " Napoli milionaria " è un incompreso ma in lui l' impatto con gli orrori della guerra genera una nuova maturità e consapevolezza che gli consentono di imporsi in seno alla famiglia e di trovare nella solidarietà fra i suoi membri la forza di affrontare i disastri che la guerra ha lasciato dietro di sè.
Nel 1946 scrive:" Questi fantasmi " che ripete il tema a lui caro dell' incomprensione fra gli uomini, della solitudine e della solidarietà vista come ancora di salvezza.
Per questa commedia e la successiva " Grande magia " per le quali si parlò di " pirandellismo " in Eduardo, è importante il giudizio di G. Pullini: " In Eduardo il dramma non consiste nell' impossibilità di trovare un linguaggio comune tra due realtà di cui è andata perduta la connessione logica ma...fra due realtà di cui è andato perduto il collegamento morale...Insomma da dramma intellettuale che sfiora la metafisica in Pirandello, si fa ( in Eduardo ) dramma di costume, di colpevolezza e di innocenza.".
Nelle commedie seguenti i mali della società sono affrontati da Eduardo con sempre maggiore amarezza: il trionfo della dignità basata sulla menzogna: " Le bugie hanno le gambe lunghe ", la rinuncia definitiva al colloquio con gli altri : " Le voci di dentro ", lo smembrarsi del nucleo familiare: " Mia famiglia ".
In alcune come: " Il figlio di Pulcinella " e " Sabato domenica e lunedì "affiora la speranza nei giovani quali fondatori di un mondo migliore.
Pirandello, negli ultimi anni della sua produzione si stacca dalle preoccupazioni esistenziali e, nelle sue ultime commedie, ritrova il senso del misterioso, del miracoloso, della bellezza del mondo, il senso della poesia in un ritrovato amore per la natura.
Eduardo, al contrario, ha continuato a scandagliare i rapporti fra uomo e società perdendo man mano la speranza in una possibile solidarietà fra gli uomini.
L' essere umano è condannato alla solitudine e al perpetuo giudizio e condizionamento da parte degli altri.
Un lavoro a sè, nella produzione di Eduardo è: " L' arte della commedia ", in cui l' autore stesso parlando dei personaggi li definisce: " ...non personaggi in cerca d' autore ma attori in cerca di personalità..." frase che ribadisce, ancora una volta, la sostanziale differenza con Pirandello; non persone in cerca di una loro identità ma uomini forniti di una precisa personalità che cercano una dimensione sociale in cui esplicarla senza soggiacere a pressioni e incomprensioni di un mondo che non sa o non vuole comprenderli.